
Michail Aleksandrovic Solochov è nato a Kruzilino [Rostov] nel 1905, la sua nascita in terra cosacca, sul Don, influì sulla tematica e sullo stile delle sue opere. In mezzo ai cosacchi visse fino al 1918, partecipando poi, con una banda bolscevica, alla guerra civile. Tornato sul Don dopo una parentesi moscovita, iniziò la sua monumentale narrativa epica con i Racconti del Don (1925). In una tonalità derivata in gran parte dal realismo tolstojano ma irrobustita dalla violenza espressiva del folclore cosacco, tracciò l’epopea della sua gente nel perentorio scenario della rivoluzione. Nell’ampio romanzo Il placido Don (1928-1940) la storia non è fatta da uomini ma da eroi: Grigorij Melechov, la sua amante Aksinia, i compagni di lotta nell’armata di cavalleria del leggendario Budënnyi, lo stentoreo Mishka Koshevoj, sullo sfondo dell’antichissima terra dei cosacchi. Il romanzo è diviso in quattro parti: Il placido Don (1928), La guerra continua (1929), I rossi e i bianchi (1933), Il colore della pace (1940). Protagonista è Grigorij Melechov, cosacco del Don, promosso sotto-ufficiale nel corso della prima guerra mondiale sul fronte russo-tedesco. Allo scoppio della rivoluzione è per l’abolizione dello zarismo ma, nemico dei bolscevichi, guida una banda armata contro di loro, nella Russia meridionale. I bianchi lo trattano con diffidenza; dopo la spaventosa ritirata del Kuban al seguito dei generali bianchi Denikin e Wrangel, tra pestilenze e orrendi massacri, Melechov si rende conto che la causa dei bianchi è persa, decide di non seguire gli avanzi delle armate controrivoluzionarie che si imbarcano a Novorossijk per Costantinopoli. Resta e attende i bolscevichi. Entra nell’armata a cavallo del generale Budënnyi e partecipa alla campagna di Polonia. Il suo passato di comandante degli antisovietici lo rende sospetto e viene presto smobilitato. Fa ritorno al suo villaggio amministrato dai comunisti. Il presidente del soviet locale, suo cognato e vecchio amico Mishka Koshevoy lo accoglie con ostilità. Minacciato e perseguitato dai burocrati e dai politici, si nasconde, si unisce ai cosacchi che assaltano i distaccamenti rossi mandati a requisire vettovaglie. Con lui combattono i contadini della zona, incapaci però di opporsi all’Armata Rossa e presto sconfitti. Melechov dopo sette anni di lotte su tutti i fronti, dopo atti eroici, ferite, privazioni, è solo, senza nessun legame, confuso e amareggiato: moglie e genitori sono morti, l’amante uccisa, la casa semidistrutta. Gli rimane il figlio: con lui, sulla terra che lo ha visto nascere, ricomincerà una nuova vita. Da questo filone centrale si dipartono innumerevoli episodi, che danno al romanzo l’andamento di una grande epopea storica sullo sfondo della sconfinata steppa russa. Alcuni critici hanno indicato ne – Il placido Don – il più alto esempio di realismo socialista; per altri invece è opera che ripete con abilità i temi del realismo psicologico tradizionale.
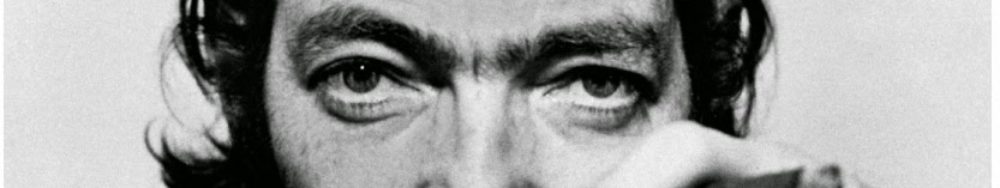




![Veren'ka Olesova (Sírin Classica) di [Maksim Gor'kij]](https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/41F65KW6m-L.jpg)
![Cevengur (Letture Einaudi Vol. 60) di [Platonov, Andrej]](https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/21ABwY4FzhL.jpg)
![Il mare della giovinezza (Tascabili e/o) di [Platonov, Andrej]](https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/51VsoD4HCUL.jpg)
![Il maestro e Margherita di [Bulgakov, Michail]](https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/410Q-fhco4L.jpg)
