
Archivi tag: Filosofia
Fritjof Capra – Il Tao della fisica

Lo scopo dichiarato del bellissimo libro di Capra è di dimostrare che esiste una sostanziale armonia tra lo spirito della saggezza orientale e le concezioni più recenti della scienza occidentale. La fisica moderna va ben al di là della tecnica, «la via – il Tao – della fisica può essere una via con un cuore, una via rivolta alla conoscenza spirituale e alla realizzazione di sé». Con uno stile piano ma appassionato, l’autore spiega al lettore da una parte i concetti, i paradossi e gli enigmi della teoria della relatività, della meccanica quantistica e del mondo submicroscopico; e, dall’altra, gli fa assaporare il fascino profondo e sconcertante delle filosofie mistiche orientali
Plutarco – Tutti i moralia

Walter Benjamin – Diario moscovita

«Qui sono da settimane alle prese col gelo fuori e col fuoco dentro», scrive Benjamin da Mosca all’amico Kracauer, sottolineando che il suo proposito è di «tornare arricchito di immagini visive, non di teorie». Due mesi cruciali, tra la fine del 1926 e l’inizio del 1927, lo immettono in un vortice di incontri e di passioni, ne stimolano lo spirito d’osservazione. A indurlo a questo viaggio è il desiderio di conoscere più da vicino la situazione russa, di stabilire un rapporto fecondo con esponenti della vita artistica e letteraria sovietica, ma è anzitutto l’amore per la rivoluzionaria lettone Asja Lacis, conosciuta a Capri nel 1924. Queste pagine di diario, «il documento di gran lunga più personale – assolutamente e crudelmente franco – fra quelli che ci restano su periodi importanti della sua vita» – come dice Scholem – testimoniano di un duplice scontro di Benjamin con la realtà. Da un lato con una Russia che andava inesorabilmente irrigidendosi nello stalinismo e nella frantumazione di ogni ipotesi di cultura e arte rivoluzionaria e dall’altro con l’impossibilità di instaurare un rapporto sereno con Asja. In questo diario, steso con mano di grande scrittore, un universo in bilico viene descritto nei suoi particolari più reconditi con tutta la sensibilità di un uomo attratto anzitutto dalle piccole cose, da un errante, sempre sul punto di partire. Colui che, dopo l’addio ad Asja e a Mosca «con la grande valigia in grembo, percorse piangendo le strade che imbrunivano, verso la stazione».
Roberto Calasso – L’innominabile attuale
Cari amici, entriamo in ottobre. In attesa di cominciare il nostro viaggio nella Rivoluzione russa, previsto, ricordo, per metà mese, mi permetto di consigliarvi un piccolo antipastino. Un libro che non c’entra nulla con l’argomento che andremo ad affrontare, ma è fresco fresco di uscita e non ho resistito… spero che apprezziate.

Turisti, terroristi, secolaristi, hacker, fondamentalisti, transumanisti, algoritmici: sono tutte tribù che abitano e agitano “l’innominabile attuale”. Mondo sfuggente come mai prima, che sembra ignorare il suo passato, ma subito si illumina appena si profilano altri anni, quel periodo fra il 1933 e il 1945 in cui il mondo stesso aveva compiuto un tentativo, parzialmente riuscito, di autoannientamento. Quel che venne dopo era informe, grezzo e strapotente. Nel nuovo millennio, è informe, grezzo e sempre più potente. Auden intitolò “L’età dell’ansia” un poemetto a più voci ambientato in un bar a New York verso la fine della guerra. Oggi quelle voci suonano remote, come se venissero da un’altra valle. L’ansia non manca, ma non prevale. Ciò che prevale è l’inconsistenza, una inconsistenza assassina. È l’età dell’inconsistenza.
P.s. ebook dedicato a pierre (un tempo conosciuto come Matteo Carlini)
Elias Canetti – Il libro contro la morte

Il libro più importante della sua vita, Canetti lo portò sempre dentro di sé ma non lo compose mai. Per cinquant’anni procrastinò il momento di ordinare in un testo articolato i numerosissimi appunti che, nel dialogo costante con i contemporanei, con i grandi del passato e con i propri lutti familiari, andava prendendo giorno dopo giorno su uno dei temi cardine della sua opera: la battaglia contro la morte, contro la violenza del potere che afferma se stesso annientando gli altri, contro Dio che ha inventato la morte, contro l’uomo che uccide e ama la guerra. Una battaglia che era un costante tentativo di salvare i morti – almeno per qualche tempo ancora – sotto le ali del ricordo: «noi viviamo davvero dei morti. Non oso pensare che cosa saremmo senza di loro».
Umberto Curi – I figli di Ares. Guerra infinita e terrorismo
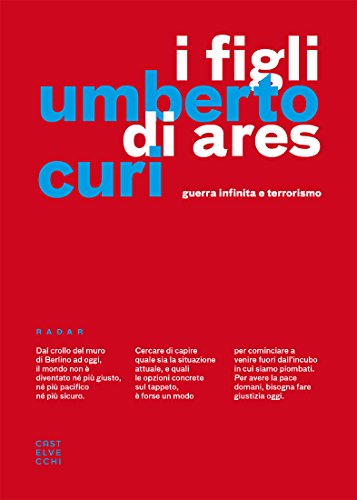
Thomas Nagel – Questioni Mortali. Le risposte della filosofia ai problemi della vita

Giorgio Colli – Per un’ enciclopedia di autori classici

Francesco Saverio Festa – Das ressentiment. Da Nietzsche a Scheler: quale edificazione della morale?

