
Archivi autore: Natjus
Stefano Mancuso – La nazione delle piante

Infornata 20 febbraio 2019 – Invece del caffè vi offro consigli

…e perché? perché oggi è il mio genetliaco. Sono 30 tondi tondi e sento ormai incedere la decadenza, ho sempre più sonno, cala la libido, piano piano offrirò sempre meno consigli fino a che anche LDB terminerà la sua missione…
Ma oggi… politica e filosofia, con la chicca del nuovo cacciari gentilmente offertoci dal quasi omonimo Minimo Kakkiari, in arte emilio millepiani (o era il contrario?)
Se vi è piaciuta questa selezione e volete contribure al sostentamento di questo blog e all’arricchimento dei suoi archivi potete fare una bella donazione cliccando sul bannerino qui sotto
Per contrastare le tante chiacchiere che attualmente impestano i media mainstream, da Murgia alla Albright, e per ristabilire, o quantomeno cercare di ristabilire, la verità storica sto lavorando a un progetto sul fascismo per il 25 aprile. Abbiamo bisogno di tutto l’aiuto possibile. Grazie
Alberto Burgio – Gramsci. Il sistema in movimento

Enzo Traverso – Il passato. Istruzioni per l’uso

Massimo Cacciari – La mente inquieta. Saggio sull’Umanesimo

Susan George – L’america in pugno. Come la destra si è impadronita di istituzioni, cultura, economia
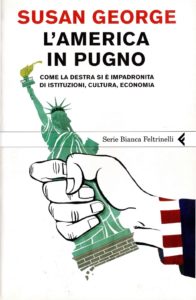
Barrington Jr. Moore – Le origini religiose della persecuzione nella storia

Nel ripetersi storico dei massacri di massa, dei rigurgiti sanguinari di intolleranza, delle persecuzioni di cui ogni epoca, non esclusa la nostra, ha provato la piaga, colpisce più che la differenza la somiglianza: «sono state le somiglianze – osserva Barrington Moore – a dare risultati così tremendi». L’eminente storico americano – che con un libro celebre, Le origini sociali della dittatura e della democrazia, ha offerto una chiave originale per comprendere la storia comparata, andando a cercare nelle basi sociali (ideologiche, istituzionali, culturali, oltre che economiche) la causa della differenza o della ripetizione -applica lo stesso sistema di indagine al caso della persecuzione. E ricostruisce, attraverso alcuni eventi speciali presi come esempi tipici – dall’Israele dell’Antico Testamento, al Terrore della Rivoluzione francese, dalle Guerre di religione, al sistema delle caste indiane e alla Cina confuciana – lo schema dinamico di quei «processi che sfociano nella approvazione morale della crudeltà». Al di sotto vi è sempre un’idea di purezza morale che d’improvviso, per circostanze diverse, si fa strada tra gli eventi e fissa il perimetro di un’identità comune che si sente minacciata dai soggetti attivi di una contaminazione percepita come abbastanza forte da deumanizzarne e demonizzarne i portatori. Una coppia di opposti inconciliabili, puri contro impuri, che si trovano entro le culture derivate dalle grandi religioni monoteiste, ma che è invece estranea alle altre culture dove l’impuro, benché degradato e intoccabile, viene considerato elemento integrante della comunità in quanto destinato a trattare e manipolare l’immondo. Una situazione tutt’altro che idillica, visto che il prezzo da pagare era la rigida divisione in caste e l’immobilità sociale, che oggi, comunque, l’intrusione dell’Occidente ha sconvolto. «Tanto tempo fa, diciamo dopo la fine della II guerra mondiale, pareva che le battaglie contro le forme più virulente dell’irrazionalità e dell’intolleranza fossero finite e vinte. Potevamo rivolgerci alla lotta contro l’ignoranza, contro la fame e le malattie, e magari goderci anche un po’ la vita. A mezzo secolo di distanza quella visione, col ritorno di tutti i vecchi spettri e la creazione di nuovi orrori, sembra essere stata la grande illusione del XX secolo».
R.P. Wolff, B. Moore jr, H. Marcuse – Critica della tolleranza
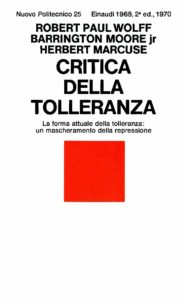
«Tempo fa – scrivono gli autori di questo volume – ci accordammo per stendere i nostri pensieri intorno alla tolleranza e al posto che occupa nell’atmosfera politica che ci circonda. Partendo da punti di vista molto diversi e attraverso strade molto diverse, siamo tutti e tre arrivati all’incirca alla stessa conclusione. Ad ognuno di noi la teoria e la pratica oggi prevalenti della tolleranza si sono rivelate dopo attento esame essere in varia misura nient’altro che maschere ipocrite per coprire realtà politiche spaventose. L’indignazione sale di saggio in saggio. Noi speriamo, forse invano, che il lettore seguirà i gradini del ragionamento che ci hanno condotto a questo risultato. V’è, dopo tutto, un senso di offesa e di indignazione che accende l’intelletto oltre che il cuore».
Roberto Esposito – Termini della politica vol. 1
![Termini della Politica vol. 1: Comunità, Immunità, Biopolitica di [Esposito, Roberto]](https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/31Jx9%2Bd6AFL.jpg)
Comunità, immunità e biopolitica sono le categorie fondamentali attraverso le quali Roberto Esposito ha elaborato un pensiero tra i più originali e apprezzati della filosofia continentale contemporanea. Pubblicato originariamente nel 2008, Termini della politica ha inaugurato un nuovo modo di pensare la politica, nel momento in cui, all’esaurimento del lessico moderno, si è trovata a interpellare direttamente la vita umana nella sua dimensione biologica. Dopo essere stata tradotta in numerosi paesi stranieri (Stati Uniti, Francia, Giappone, Corea, Polonia, Brasile), l’opera riappare adesso in una nuova edizione, arricchita da altri saggi dell’autore, che ne ampliano i contenuti e allargano l’orizzonte. Il secondo volume, Politica e pensiero – due termini classici il cui rapporto segna l’intero percorso filosofico di Esposito –, rappresenta la prosecuzione ideale del primo, in un confronto sempre più teso con le grandi questioni del nostro tempo. Due libri dunque legati fra loro, ma allo stesso tempo indipendenti, che condividono l’originalità di un pensiero e il rigore di un percorso teoretico sempre più
al centro del dibattito filosofico contemporaneo.
