Fa troppo caldo per scrivere qualcosa.
Buone letture

Fa troppo caldo per scrivere qualcosa.
Buone letture
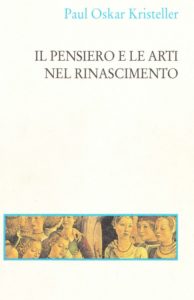
Oggetto di questi studi – divenuti ormai un punto di riferimento obbligato – sono la filosofia e le arti del Rinascimento: l’umanesimo, il platonismo e l’aristotelismo, ma anche la musica, la poesia, le arti figurative. Quel complesso di fenomeni di sensibilità e pensiero che dettero spessore e autonomia a una cultura del Rinascimento. Kristeller diffida di ogni operazione che voglia ingabbiare la storia della cultura sotto le rigide determinazioni della storia politica, economica o sociale. Anzi, difende il punto di vista secondo cui sono le idee filosofiche e artistiche ad avere influenzato in modo determinante la politica e l’economia di certe epoche storiche. I saggi qui raccolti su Ficino e Pomponazzi, sull’averroismo padovano, sul pensiero morale e sulla diffusione europea dell’umanesimo, sull’insegnamento della musica, sulla retorica, sul sistema delle arti, sono la prova migliore della fecondità di un metodo di indagine che privilegia l’autonomia di una storia intellettuale a tutto tondo, capace di restituire in pieno lo spessore e la profondità di uno dei momenti più significativi ed esaltanti della nostra vicenda intellettuale.
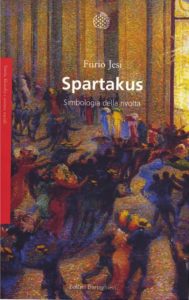
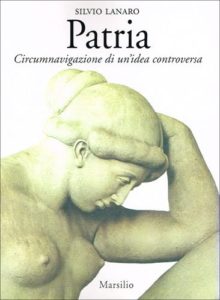
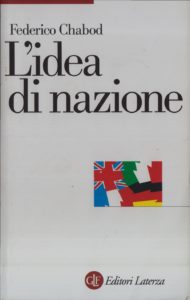
Dire senso di nazionalità, significa dire senso di individualità storica. Si giunge al principio di nazione in quanto si giunge ad affermare il principio di individualità, cioè ad affermare, contro tendenze generalizzatrici ed universalizzanti, il principio del particolare, del singolo.
Per questo, l’idea di nazione sorge e trionfa con il sorgere e il trionfare di quel grandioso movimento di cultura europeo, che ha nome Romanticismo.

L’intento di queste pagine è quello di porre una domanda: in quale modo si renderà possibile resistenza di un grande popolo cristiano nella civiltà di domani? Il problema religioso non riguarda una élite. È, al contrario, un problema che riguarda le masse. A livello delle masse, però, religione e civiltà sono strettamente dipendenti l’una dall’altra. Non esiste una vera civiltà che non sia religiosa. Inversamente, una religione di massa è possibile soltanto se sostenuta dalla diffusione della cultura.
Ora, ci sembra che oggi troppi cristiani accettino la giustapposizione di una religione personale e di una società laica. Tale concezione è rovinosa sia per la società che per la religione. Ma come trovare un’unione dell’una e dell’altra, che non assoggetti la religione ai poteri temporali e che non osservi i poteri temporali alla religione?
Le pagine che scrivo vorrebbero essere un invito a questa ricerca di primaria importanza per il futuro

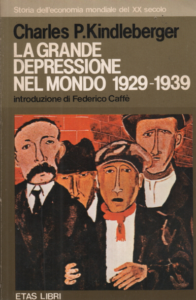
Le crisi monetarie che da anni si susseguono in quasi tutti i paesi del mondo spingono gli economisti a ricercare le cause e il significato della grande depressione degli anni trenta quasi a “desumerne insegnamenti – come scrive Federico Caffè in una interessante introduzione al volume – per una migliore comprensione della depressione inflazionistica che il mondo sta sperimentando a partire dalla prima parte degli anni settanta”. La tesi che Kindleberger sviluppa nel suo volume, sostenuta da un ricco materiale storico ed economico, è senz’altro una delle più originali: le ragioni che possono spiegare la lunghezza e la profondità della depressione mondiale vanno ravvisate nella incapacità della Gran Bretagna e nella mancata volontà degli Stati Uniti di accettare le responsabilità inerenti la posizione di leadership; la causa fondamentale della crisi va perciò ricercata soprattutto nell’instabilità del sistema economico e monetario internazionale, instabilità su cui ancora oggi il mondo s’interroga alla ricerca di valide soluzioni

Un cristiano, Werner Post, e un marxista, Alfred Schmidt, discutono il significato attuale, lo sviluppo storico, le contraddizioni e le implicazioni rivoluzionarie del materialismo. Dopo aver analizzato il ruolo ideologico-politico del materialismo francese del ‘700 e aver ampiamente indagato i caratteri di quello marxista, gli autori si soffermano su aspetti del pensiero materialistico tanto essenziali quanto raramente tematizzati, come il posto dell’uomo e della Terra nell’universo, l’inesorabilità delle leggi di natura, il problema della malattia e della morte…
Il materialismo al centro del dialogo non è solo una teoria rivoluzionaria; è anche una visione del mondo in grado di dare una risposta coerente e rigorosa alle domande dell’uomo.
