![Considerazioni del signor Zeta: ovvero Briciole da lui lasciate cadere, e raccolte da chi lo stava ad ascoltare (L'Arcipelago Einaudi Vol. 222) di [Enzensberger, Hans Magnus]](https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/41Hs5aXU8fL.jpg)
«Tutte le cose intelligenti sono già state pensate, bisogna solo ripensarle», ha scritto Goethe. In questo senso il libretto di Enzensberger si inserisce in una tradizione che da Epicuro conduce a Montaigne, Lichtenberg, Nietzsche, e infine a Brecht e Adorno. Le Considerazioni del signor Zeta non sono quindi una costruzione hegelianamente strutturata, ma pensieri «in libertà» che non intendono necessariamente presentarsi come originali e rivoluzionari, e nemmeno mascherare eventuali contraddizioni (coercizioni queste, dalle quali l’autore ha preso allegramente le distanze ormai da molti anni). Zeta è un signore grassottello, vestito in modo antiquato (porta una bombetta marrone!), abituato a una vita di agi (di nuovo Epicuro?), che ogni pomeriggio prende posto sulla panchina di un parco e coinvolge i passanti in allegre discussioni. Sul suo conto il pubblico, e con esso anche i curatori che si sono presi la briga di annotare quanto andava dicendo, ha opinioni discordanti: alcuni lo considerano un saggio, altri uno sputasentenze, una «persona poco seria», un clown, un polemico filosofo. Molti scuotono la testa e tirano via, alcuni si fermano. Per quanto differenziati siano i giudizi, è comunque indubbio che si tratta di un oratore fuori dagli schemi, che può dire cose che altri preferiscono tenere per sé, mettere in discussione pregiudizi e verità acquisite. Una sola volta lo abbandona la sua tranquillità, la sua pacatezza: quando uno studente di filosofia lo accusa di essere un aforista. Perché l’aforisma ha in sé un che di definito, di apodittico, qualità dalle quali il signor Zeta rifugge: le contraddizioni non lo turbano piú di tanto, l’esistenza umana ne è piena, e lui preferisce relativizzare e appunto contraddire (anche se stesso). E cosí, pomeriggio dopo pomeriggio, questo insolito pensatore riflette sulla storia, sull’intelligenza umana (considera sopravvalutata quella dei contemporanei), sulla scienza (l’inutilità delle missioni nello spazio con uomini a bordo), la tecnica, la collettività, i designer (il cui obiettivo primario sembra quello di rendere «inutilizzabili tutti gli oggetti di uso comune»), ma anche sulla politica e gli uomini politici (Che Guevara in primis). Non mancano, nel repertorio del signor Zeta – che dice di essere un dilettante privo di ambizioni: «ho le mie idee e sono contento quando qualcuno mi fa ricredere su qualcosa» -, i consigli su come migliorare la vita: ad esempio visitare un orto botanico – un’operazione sana per il corpo e per la mente – dove ci accoglie una grande varietà di nomi scientifici che sono infinitamente superiori alla transitorietà del linguaggio cui siamo costretti a confrontarci ogni giorno nei media. Il tempo passa, inizia a fare freddo, arriva l’inverno e il signor Zeta si ritira, scompare dal microcosmo del parco. Di lui restano le briciole che ha lasciato cadere e che qualcuno ha raccolto.
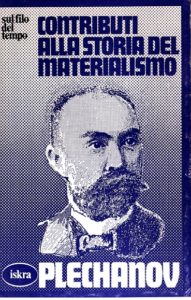

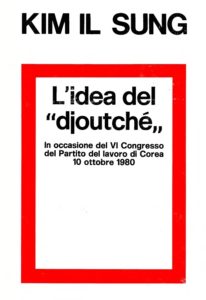
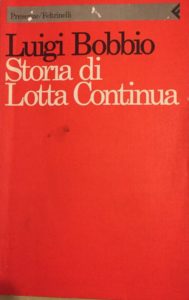
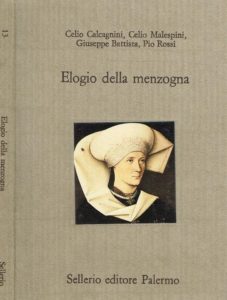
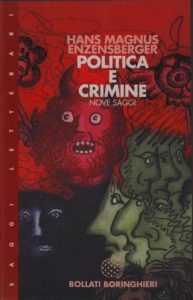
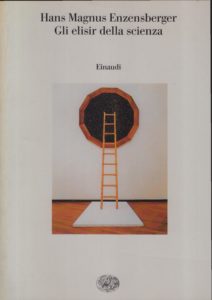
![Panopticon: Venti saggi da leggere in dieci minuti (Vele) di [Enzensberger, Hans Magnus]](https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/41Yyp2ZrCQL._SY346_.jpg)
![Mausoleum: Trentasette ballate tratte dalla storia del progresso (Collezione di poesia Vol. 444) di [Enzensberger, Hans Magnus]](https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/51RUC5dKjdL.jpg)

![Considerazioni del signor Zeta: ovvero Briciole da lui lasciate cadere, e raccolte da chi lo stava ad ascoltare (L'Arcipelago Einaudi Vol. 222) di [Enzensberger, Hans Magnus]](https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/41Hs5aXU8fL.jpg)